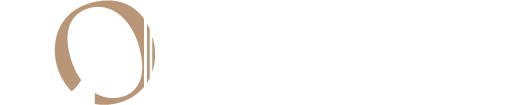Il bullismo ed il cyberbullismo sono due fenomeni a matrice sociale, particolarmente allarmanti perché coinvolgono tristemente giovani e adolescenti della nostra società.
Per bullismo si intende quel comportamento di prevaricazione e sopraffazione che viene posto in essere da una persona, o da un gruppo di persone, nei confronti di un altro soggetto considerato “debole”, attraverso violenze fisiche o psicologiche.
Si parla, invece, di cyberbullismo quando questi comportamenti vessatori sono virtuali in quanto realizzati mediante lo strumento di internet.
Entrambi i fenomeni comportano serie e significative ripercussioni sulla sfera personale della vittima, in particolar modo a livello psicologico.
Il bullismo di per sé non rappresenta un reato penale, tuttavia, alcune condotte assunte dal “bullo” sono riconducibile nell’alveo di fattispecie penali come il reato di percosse (art. 581 c.p.), il reato di lesione (art. 582 c.p.), il reato di diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.), il reato di minaccia (art. 612 c.p.), il reato di stalking (art. 612 bis c.p.) ed infine il reato di violenza privata ai sensi dell’art. 610 del codice penale.
A tal proposito, la Corte Suprema di Cassazione , V Sezione Penale, è intervenuta con la sentenza n. 163 del 5 gennaio 2021 affermando che, è configurabile il reato di violenza privata ex art. 610 c.p., contro colui che ha posto in essere atti di bullismo nei confronti del proprio compagno di scuola, poiché l’aver simulato un rapporto sessuale sul corpo della vittima, l’averla presa a calci ed insultata con parolacce scritte sui libri scolatici, rappresentano atti lesivi della libertà psichica e fisica: prezioso bene giuridico tutelato non solo dal diritto penale, bensì anche dalla Carta Costituzionale.
Nel tentativo di contrastare e prevenire i predetti fenomeni, in particolar modo quello del cyberbullismo, il Legislatore ha approvato la legge n. 71/2017, la quale prevede la possibilità di ricorrere a strumenti di tutela, in particolar modo a favore della dignità del minore, anche in assenza di denuncia-querela da parte della persona offesa, come l’ammonimento ad opera del Questore, ossia un “invito”, da parte di quest’ultimo, ad interrompere l’azione persecutoria, ingiuriosa e/o diffamatoria.
Vi è di più. La vittima di cyberbullismo può presentare un’istanza al gestore del sito internet, piuttosto che del social-media, chiedendo l’oscuramento, la rimozione oppure il blocco di ogni dato personale diffuso in rete, previa conservazione dei dati originali e, nell’ipotesi in cui ciò non accadesse, il soggetto interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali al fine di ricevere una tutela ad hoc.
La Legge sul cyberbullismo prevede altresì un codice di autoregolamentazione per la prevenzione ed il contrasto a tale fenomeno a cui devono attenersi, non solo tutti gli operatori che operano nel networking, bensì anche tutti gli enti che prestano servizi socio-educativi come, ad esempio, le scuole poiché il bullismo, molto spesso, nasce e si rinforza all’interno dell’ambito scolastico.
I contegni assunti dal “bullo” possono anche dar vita ad una richiesta di risarcimento del danno da parte della vittima per effetto del dispositivo di cui all’art. 2043 codice civile, secondo cui, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire sia il danno morale che il danno biologico.
Preme evidenziare inoltre come (a differenza di quanto accade nel diritto penale dove la responsabilità è esclusivamente personale) in ambito civilistico le conseguenze degli illeciti commessi da minorenni ricadano sui genitori, i quali potranno essere chiamati a rispondere del danno cagionato dai propri figli minori. Dinanzi, dunque, ad una situazione di coercizione e soggezione capace di generare nella vittima un’innegabile sofferenza fisica ma soprattutto psicologia, la legge fornisce efficaci strumenti di tutela idonei a proteggere l’offeso da ogni tipo di prevaricazione e sopraffazione perpetrato nei suoi confronti.